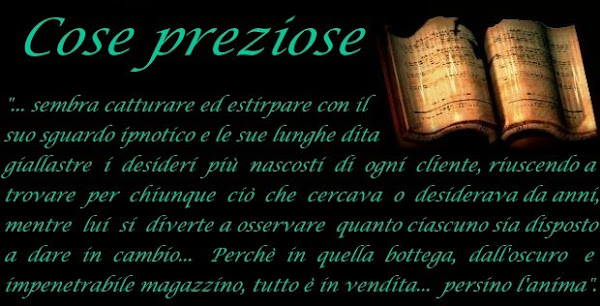“O Tosco, che per la città del foco
vivo ten vai così parlando onesto,
piacciati di restare in questo loco.
La tua loquela ti fa manifesto
di quella nobil patria natio,
alla qua’ forse fui troppo molesto.”
Subitamente questo suono uscio
d’una dell’arche; però m’accostai,
temendo, un poco più al duca mio.
Ed ei mi disse: “Volgiti: che fai?
Vedi là Farinata che s’è dritto:
dalla cintola in su tutto il vedrai.”
I’ avea già il viso nel suo fitto,
ed ei s’ergea col petto e colla fronte
come avesse lo inferno in gran dispitto.
E l’animose man del duca pronte
mi pinser tra le sepolture a lui,
dicendo: “Le tue parole sien conte.”
Com’io al piè della sua tomba fui,
guardommi un poco, e poi, quasi sdegnoso,
mi dimandò: “Chi fur li maggior tui?”
Io, ch’era di ubbidir desideroso,
non gliel celai, ma tutto gliel’apersi;
ond’ei levò le ciglia un poco in soso,
poi disse: “Fieramente furo avversi
a me e a’ miei primi e a mia parte,
sì che per due fiate li dispersi.”
“S’ei fur cacciati, ei tornar d’ogni parte,”
rispuos’io lui, “l’una e l’altra fiata;
ma i vostri non appreser ben quell’arte.”
[...]
E: “Se,” continuando al primo detto
“S’egli hanno quell’arte,” disse, “male appresa,
ciò mi tormenta più che questo letto.
Ma non cinquanta volte fia raccesa
la faccia della donna che qui regge,
che tu saprai quanto quell’arte pesa.”
Inferno, canto X versi 22-51 e 76-81
mercoledì 9 aprile 2008
lunedì 7 aprile 2008
Solitudine
L’idea di utilizzare questo spezzone mi tentava da parecchio tempo, eppure solo adesso le ho dato forma. C’è un motivo. Qualche sera fa ho parlato con un’amica, la conosco da poco, ma mi sento davvero in sintonia con lei. È strano come una persona che sta tanto lontano da me riesca a conoscermi molto meglio della maggior parte di quelle che ho intorno tutti i giorni. L’argomento di cui si è parlato era proprio questo, ma non mi va di rendere pubbliche quelle parole che ci siamo scambiati, per quanto poche possano essere le persone che leggeranno queste pagine. Quello che mi importa dire è che il mio stato d’animo attuale è molto simile a quello di JD in questo frammento, e la cosa mi rende un po’ triste. Ma sapere di avere persone come questa amica su cui poter contare e con le quali confidarmi è molto rassicurante, in questo momento. Per questo, visto che so che fai spesso un salto da queste parti, ci tengo a dirti grazie per le parole che mi hai detto. E lo so che la vita non è un telefilm e i telefilm non sono la vita, ma nel caso di “Scrubs”, come ho avuto già modo di dire in occasione del post “A spasso con il camice”, le due cose si avvicinano molto. Almeno, questo è quello che trasmette a me. Non mi dilungo oltre sull’argomento, come vedete, e, a parte il titolo, non ho fatto parola di quello di cui si parla. Tutto quello che potrei dire io, è espresso magnificamente nel monologo finale di JD, e soprattutto nello sfogo con i suoi amici alla mensa. Perché vorrei che tutti vi rendeste conto di quanto siete fortunati ad avere certe cose, e non auguro a nessuno di scoprire come ci si sente senza.
“Il peggior modo di sentire la mancanza di qualcuno è esserci seduto accanto e sapere che non l’avrai mai”.
domenica 6 aprile 2008
L'orgoglio di Baghdad

Forse è troppo facile, troppo banale, troppo scontato parlare in questi anni della guerra in Iraq. Forse, anche se non vorremmo, non possiamo non tirare un sospiro di sollievo quando un silenzio ristoratore copre queste notizie, e al contrario uno sbuffo ci esce inconsapevolmente dalle labbra ogni volta che sul giornale leggiamo dell’ennesima bomba, da qualunque parte essa venga. Figuriamoci cosa può voler dire fare un fumetto, anzi una graphic novel, proprio su questo tema.
Conoscevo Brian K. Vaughan per altre sue opere, le più importanti delle quali sono certamente “Y: l’ultimo uomo” e “ Ex machina”. Non avevo idea di chi fosse Niko Henrichon, ma è bastata una rapida occhiata alla copertina per far mi dire che volevo questo fumetto. Era sigillato, quindi non ho potuto neanche sfogliarlo prima di comprarlo, e non conoscevo nessuno che l’avesse già letto, quindi andavo totalmente alla cieca. Eppure, qualcosa mi diceva che non me ne sarei pentito, perché quegli occhi in copertina mi dicevano che c’è qualcosa di sbagliato in quel silenzio ristoratore, che è necessario parlare. E scrivere. E disegnare.
mi dire che volevo questo fumetto. Era sigillato, quindi non ho potuto neanche sfogliarlo prima di comprarlo, e non conoscevo nessuno che l’avesse già letto, quindi andavo totalmente alla cieca. Eppure, qualcosa mi diceva che non me ne sarei pentito, perché quegli occhi in copertina mi dicevano che c’è qualcosa di sbagliato in quel silenzio ristoratore, che è necessario parlare. E scrivere. E disegnare.
 mi dire che volevo questo fumetto. Era sigillato, quindi non ho potuto neanche sfogliarlo prima di comprarlo, e non conoscevo nessuno che l’avesse già letto, quindi andavo totalmente alla cieca. Eppure, qualcosa mi diceva che non me ne sarei pentito, perché quegli occhi in copertina mi dicevano che c’è qualcosa di sbagliato in quel silenzio ristoratore, che è necessario parlare. E scrivere. E disegnare.
mi dire che volevo questo fumetto. Era sigillato, quindi non ho potuto neanche sfogliarlo prima di comprarlo, e non conoscevo nessuno che l’avesse già letto, quindi andavo totalmente alla cieca. Eppure, qualcosa mi diceva che non me ne sarei pentito, perché quegli occhi in copertina mi dicevano che c’è qualcosa di sbagliato in quel silenzio ristoratore, che è necessario parlare. E scrivere. E disegnare. Nell’aprile 2003, il cielo di Baghdad è caduto. Quattro leoni (un maschio, due femmine e un cucciolo) fuggono dallo zoo dove vivevano, semidistrutto dalle bombe. Non capiscono cosa sia successo, non sanno dove andare, come procurarsi il cibo. Fino ad allora erano vissuti all’ombra dei custodi, che davano loro da mangiare e li accudivano. Eppure, qualcosa si risveglia dentro di loro: il desiderio di essere liberi, l’orgoglio di essere leoni. Si avventurano in un mondo che non conoscono, incontrano altre bestie che non hanno mai visto e altre ancora che invece conoscono. Il senso del branco, sopito ma non estinto in una vita di cattività, li fa andare avanti, uno accanto all’altro. Fino a trovare il loro orizzonte. E la morte, ironica e beffarda, che li attende non appena lo raggiungono.
Nell’aprile 2003, il cielo di Baghdad è caduto. Quattro leoni (un maschio, due femmine e un cucciolo) fuggono dallo zoo dove vivevano, semidistrutto dalle bombe. Non capiscono cosa sia successo, non sanno dove andare, come procurarsi il cibo. Fino ad allora erano vissuti all’ombra dei custodi, che davano loro da mangiare e li accudivano. Eppure, qualcosa si risveglia dentro di loro: il desiderio di essere liberi, l’orgoglio di essere leoni. Si avventurano in un mondo che non conoscono, incontrano altre bestie che non hanno mai visto e altre ancora che invece conoscono. Il senso del branco, sopito ma non estinto in una vita di cattività, li fa andare avanti, uno accanto all’altro. Fino a trovare il loro orizzonte. E la morte, ironica e beffarda, che li attende non appena lo raggiungono.La storia può sembrare triste, ma non è la melanconia fine a se stessa il motivo conduttore delle vicende. Quello che risalta è invece, ancora una volta, la scelleratezza della razza umana. Una razza disposta a distruggere la natura che la circonda, a massacrarsi tra simili per il denaro, per quello da cui questo deriva, e per il potere che ne scaturisce. In antitesi alla pochezza delle azioni degli uomini, spicca la nobiltà delle scelte animali. Quelli che dovrebbero essere i rappresentanti del puro istinto, trovano invece la maturità spirituale per onorare un vecchio patto, o per mostrare rispetto per coloro che li hanno accuditi fino ad allora, anche se questo vuol dire rinunciare alla possibilità di avere cibo facilmente. Laddove invece gli umani non riescono a rinunciare al loro unico, vero istinto, quello che li porta a guidare carri armati, a lanciare bombe, a impugnare fucili: l’odio. Non è un caso che gli animali dai comportamenti più bassi siano proprio le scimmie, i più vicini all’uomo nella scala evolutiva.
melanconia fine a se stessa il motivo conduttore delle vicende. Quello che risalta è invece, ancora una volta, la scelleratezza della razza umana. Una razza disposta a distruggere la natura che la circonda, a massacrarsi tra simili per il denaro, per quello da cui questo deriva, e per il potere che ne scaturisce. In antitesi alla pochezza delle azioni degli uomini, spicca la nobiltà delle scelte animali. Quelli che dovrebbero essere i rappresentanti del puro istinto, trovano invece la maturità spirituale per onorare un vecchio patto, o per mostrare rispetto per coloro che li hanno accuditi fino ad allora, anche se questo vuol dire rinunciare alla possibilità di avere cibo facilmente. Laddove invece gli umani non riescono a rinunciare al loro unico, vero istinto, quello che li porta a guidare carri armati, a lanciare bombe, a impugnare fucili: l’odio. Non è un caso che gli animali dai comportamenti più bassi siano proprio le scimmie, i più vicini all’uomo nella scala evolutiva.
 melanconia fine a se stessa il motivo conduttore delle vicende. Quello che risalta è invece, ancora una volta, la scelleratezza della razza umana. Una razza disposta a distruggere la natura che la circonda, a massacrarsi tra simili per il denaro, per quello da cui questo deriva, e per il potere che ne scaturisce. In antitesi alla pochezza delle azioni degli uomini, spicca la nobiltà delle scelte animali. Quelli che dovrebbero essere i rappresentanti del puro istinto, trovano invece la maturità spirituale per onorare un vecchio patto, o per mostrare rispetto per coloro che li hanno accuditi fino ad allora, anche se questo vuol dire rinunciare alla possibilità di avere cibo facilmente. Laddove invece gli umani non riescono a rinunciare al loro unico, vero istinto, quello che li porta a guidare carri armati, a lanciare bombe, a impugnare fucili: l’odio. Non è un caso che gli animali dai comportamenti più bassi siano proprio le scimmie, i più vicini all’uomo nella scala evolutiva.
melanconia fine a se stessa il motivo conduttore delle vicende. Quello che risalta è invece, ancora una volta, la scelleratezza della razza umana. Una razza disposta a distruggere la natura che la circonda, a massacrarsi tra simili per il denaro, per quello da cui questo deriva, e per il potere che ne scaturisce. In antitesi alla pochezza delle azioni degli uomini, spicca la nobiltà delle scelte animali. Quelli che dovrebbero essere i rappresentanti del puro istinto, trovano invece la maturità spirituale per onorare un vecchio patto, o per mostrare rispetto per coloro che li hanno accuditi fino ad allora, anche se questo vuol dire rinunciare alla possibilità di avere cibo facilmente. Laddove invece gli umani non riescono a rinunciare al loro unico, vero istinto, quello che li porta a guidare carri armati, a lanciare bombe, a impugnare fucili: l’odio. Non è un caso che gli animali dai comportamenti più bassi siano proprio le scimmie, i più vicini all’uomo nella scala evolutiva.Un romanzo a fumetti intenso e coinvolgente, che vale la pena avere in libreria per tornare a rileggerlo ogni tanto, giusto quando è necessario ritrovare qualcosa su cui soffermarsi a pensare.
“C’è una cosa nera, sotto la terra, ragazzo. Veleno. Quando i bipedi combattono, lo sputano in cielo, e lo versano in mare.”
“Bipedi? Vuoi dire i custodi?”
“Custodi, bipedi, Uomini... Non importa come li chiami, sono tutti uguali.”
“E per cosa combattono?”
“E che ne so, figliolo... Che mi importa, ormai.”
sabato 5 aprile 2008
In memoria 16 - Eresiarchi
“La gente che per li sepolcri giace
potrebbesi veder? Già son levati
tutti i coperchi, e nessun guardia face.”
E quelli a me: “Tutti saran serrati,
quando di Josafat qui torneranno
coi corpi che lassù hanno lasciati.
Suo cimiterio da questa parte hanno
con Epicuro tutti i suoi seguaci,
che l’anima col corpo morta fanno.”
Inferno, canto X versi 7-15
potrebbesi veder? Già son levati
tutti i coperchi, e nessun guardia face.”
E quelli a me: “Tutti saran serrati,
quando di Josafat qui torneranno
coi corpi che lassù hanno lasciati.
Suo cimiterio da questa parte hanno
con Epicuro tutti i suoi seguaci,
che l’anima col corpo morta fanno.”
Inferno, canto X versi 7-15
Perchè i pesci non affoghino
 Era da un po’ di tempo che avevo voglia di un libro sostanzioso, uno di quelli di cui senti il peso in senso fisico, mentre lo leggi seduto in treno o in poltrona e le dita si stancano a tenerlo. Quel giorno entrai in libreria proprio con questo scopo: trovare un volumone che mi avrebbe impegnato per un po’. Mi tornavano alla mente i tempi in cui avevo letto “Il petalo cremisi e il bianco” o “La montagna dell’anima” (per citare due tra i più recenti), e andavo in cerca tra gli scaffali senza trovare niente che mi stuzzicasse, a parte qualche libro più ‘classico’, tipo “Don Chisciotte”. A un certo punto, quasi se ne stesse in disparte, sbirciò da una mensola questo libro. Lo notai perché il titolo era curioso, e la quarta di copertina mi incuriosì ancora di più. Un occhiata al risvolto fu il colpo finale: andava comprato. Stranamente, non dovette aspettare il suo turno per essere letto, perché avevo magicamente esaurito tutto ciò che avevo comprato negli ultimi mesi. Il tempo di foderarlo con la pellicola trasparente, ed ero pronto a cominciare.
Era da un po’ di tempo che avevo voglia di un libro sostanzioso, uno di quelli di cui senti il peso in senso fisico, mentre lo leggi seduto in treno o in poltrona e le dita si stancano a tenerlo. Quel giorno entrai in libreria proprio con questo scopo: trovare un volumone che mi avrebbe impegnato per un po’. Mi tornavano alla mente i tempi in cui avevo letto “Il petalo cremisi e il bianco” o “La montagna dell’anima” (per citare due tra i più recenti), e andavo in cerca tra gli scaffali senza trovare niente che mi stuzzicasse, a parte qualche libro più ‘classico’, tipo “Don Chisciotte”. A un certo punto, quasi se ne stesse in disparte, sbirciò da una mensola questo libro. Lo notai perché il titolo era curioso, e la quarta di copertina mi incuriosì ancora di più. Un occhiata al risvolto fu il colpo finale: andava comprato. Stranamente, non dovette aspettare il suo turno per essere letto, perché avevo magicamente esaurito tutto ciò che avevo comprato negli ultimi mesi. Il tempo di foderarlo con la pellicola trasparente, ed ero pronto a cominciare.“Perché i pesci non affoghino” parla di un viaggio. Dodici occidentali si avventurano alla volta della Cina meridionale e della Birmania. Ma in realtà sono tredici a viaggiare. Con loro c’è anche Bibi Chen, un’antiquaria di origine cinese, trapiantata a San Francisco, organizzatrice del viaggio e, allo stato attuale,... morta! Bibi muore nel suo negozio in circostanze misteriose, delle quali lei stessa non ricorda nulla, mentre ricorda tutto il resto, tutta la sua vita, dall’infanzia all’età adulta, dalla Cina all’America. Bibi doveva essere la guida del gruppo nel viaggio attraverso l’antica via birmana, il percorso che dalla Cina conduceva a quello che il nuovo governo militare ha ribattezzato Myanmar, per tagliare i ponti col passato. Ma i suoi amici, un gruppo variegato di benestanti occidentali, decidono in suo onore di partire ugualmente, anche senza di lei, perché Bibi vorrebbe così. E lei non può fare niente per evitarlo, perché in realtà sa bene che è una pessima idea per delle persone che non sanno nulla della cultura e delle tradizioni orientali avventurarsi in quei luoghi. Ma non può fare altro che seguirli con lo spirito, e con la nuova coscienza che il suo stato gli ha concesso, ‘i doni del Buddha’, che le permettono di sentire i loro pensieri.
Il romanzo unisce in sé molti motivi. Uno è quello dell’esperienza familiare di Bibi, disprezzata dalla madre adottiva, costretta a scappare con la famiglia dalla Cina e a rifugiarsi in America, a sperimentare l’esperienza dell’emigrazione. Un altro, forse quello che più balza agli occhi insieme al primo, è quello delle vicende personali dei dodici protagonisti, e dei complessi rapporti che si intrecceranno tra alcuni di loro. Ma se si guarda con attenzione si scorge un terzo motivo, molto interessante: la difficile situazione politica di quella regione, complicata ancora di più da episodi come il rapimento di turisti, e soprattutto la profonda ignoranza che gli occidentali hanno della cultura dell’estremo Oriente. Insomma, un romanzo che, sotto la veste apparentemente ironica e bonaria del racconto di viaggio, non risparmia critiche a nessuno: né all’autoritarismo dei regimi illiberali e fascistoidi tuttora presenti in molte regioni, né all’individualismo narcisistico del nostro mondo che vive avvolto nella bambagia.
“Un uomo pio spiegò ai suoi discepoli: Togliere la vita è un’azione malvagia, salvare la vita è un’azione nobile. Ogni giorno giuro di salvare cento vite. Getto la rete nel lago e la ritiro con dentro un centinaio di pesci. Metto i pesci sulla riva, dove si contorcono e si dibattono goffamente. ‘Non abbiate paura’ dico loro. ‘Vi ho salvato impedendo che affogaste’. Poco dopo i pesci si calmano e restano immobili. Eppure, è triste dirlo, arrivo sempre troppo tardi. I pesci muoiono. E siccome ogni spreco è un male, porto i pesci morti al mercato e li vendo ricavandone un certo guadagno. Con il denaro compro altre reti, così potrò salvare un maggior numero di pesci”.
mercoledì 2 aprile 2008
In memoria 15 - Le Erinni
Però che l’occhio mi avea tutto tratto
ver l’altra torre, alla cima rovente,
dove in un punto furon dritte ratto
tre furie infernal di sangue tinte,
che membra femminine avevano e atto,
e con idre verdissime eran cinte;
serpentelli e ceraste avean per crine,
onde le fiere tempie erano avvinte.
E quei, che ben conobbe le meschine
della regina dell’eterno pianto,
“Guarda,” mi disse, “le feroci Erine.
Questa è Megera dal sinistro canto;
quella che piange dal destro è Aletto;
Tesifone è nel mezzo;” e tacque a tanto.
Con l’unghie si fendean ciascuna il petto;
batteansi a palme; e gridavan sì alto,
ch’io mi strinsi al poeta per sospetto.
Inferno, canto IX versi 35-51
ver l’altra torre, alla cima rovente,
dove in un punto furon dritte ratto
tre furie infernal di sangue tinte,
che membra femminine avevano e atto,
e con idre verdissime eran cinte;
serpentelli e ceraste avean per crine,
onde le fiere tempie erano avvinte.
E quei, che ben conobbe le meschine
della regina dell’eterno pianto,
“Guarda,” mi disse, “le feroci Erine.
Questa è Megera dal sinistro canto;
quella che piange dal destro è Aletto;
Tesifone è nel mezzo;” e tacque a tanto.
Con l’unghie si fendean ciascuna il petto;
batteansi a palme; e gridavan sì alto,
ch’io mi strinsi al poeta per sospetto.
Inferno, canto IX versi 35-51
martedì 1 aprile 2008
D'un tratto nel folto del bosco
 Anche questo è uno di quei classici libri tappabuchi, che compro perché di dimensioni contenute, perché magari vengo da una lettura di mille pagine e voglio qualcosa di più leggero, o semplicemente per fare ‘conto paro’ con il prezzo di un altro acquisto. Quel giorno, contrariamente a quanto succede di solito, capitai in libreria per caso. Di regola, la libreria è una meta ragionata, esco di casa apposta per andare lì e passare una o anche due ore a sfogliare copertine. Quel giorno invece ero in zona per tutt’altro motivo, e entrai come si entrerebbe in un mercatino di quartiere. Cominciai a girare per gli scaffali, gettando un occhio qua e là, senza cercare niente in particolare. Avevo già visto altre volte questo libro, e mentalmente era finito nella casella del ‘forse un giorno lo prenderò, ma non oggi’. Invece quel giorno continuavo a guardare quella copertina blu elettrico con l’albero giallo al centro. Mi frugai le tasche, e incredibilmente c’erano proprio dieci euro (non porto mai soldi con me, tranne quando so che devo comprare qualcosa, e non era quello il caso). Combaciava tutto alla perfezione, non poteva non essere un segno, così lo comprai. Era un venerdì mattina, avevo appena finito di dare un esame, e dovevo tornare a casa a preparare la valigia per tornare in paese. Mi ci vollero dieci minuti per farlo, poi mi sedetti sul divano e cominciai a leggere. In poco più di un’ora ero arrivato a metà, ma si era fatto il momento di andare a prendere il treno. Incontrai una persona che conoscevo, ma non potevo resistere, e dovetti continuare a leggere, anche se sapevo che non è una cosa carina incontrare qualcuno che si conosce e ignorarlo per leggere. Chiusi il libro quando si cominciarono a vedere dai finestrini le prime case di Cefalù: l’avevo finito. Poco più di due ore di lettura. Credo sia il mio record assoluto.
Anche questo è uno di quei classici libri tappabuchi, che compro perché di dimensioni contenute, perché magari vengo da una lettura di mille pagine e voglio qualcosa di più leggero, o semplicemente per fare ‘conto paro’ con il prezzo di un altro acquisto. Quel giorno, contrariamente a quanto succede di solito, capitai in libreria per caso. Di regola, la libreria è una meta ragionata, esco di casa apposta per andare lì e passare una o anche due ore a sfogliare copertine. Quel giorno invece ero in zona per tutt’altro motivo, e entrai come si entrerebbe in un mercatino di quartiere. Cominciai a girare per gli scaffali, gettando un occhio qua e là, senza cercare niente in particolare. Avevo già visto altre volte questo libro, e mentalmente era finito nella casella del ‘forse un giorno lo prenderò, ma non oggi’. Invece quel giorno continuavo a guardare quella copertina blu elettrico con l’albero giallo al centro. Mi frugai le tasche, e incredibilmente c’erano proprio dieci euro (non porto mai soldi con me, tranne quando so che devo comprare qualcosa, e non era quello il caso). Combaciava tutto alla perfezione, non poteva non essere un segno, così lo comprai. Era un venerdì mattina, avevo appena finito di dare un esame, e dovevo tornare a casa a preparare la valigia per tornare in paese. Mi ci vollero dieci minuti per farlo, poi mi sedetti sul divano e cominciai a leggere. In poco più di un’ora ero arrivato a metà, ma si era fatto il momento di andare a prendere il treno. Incontrai una persona che conoscevo, ma non potevo resistere, e dovetti continuare a leggere, anche se sapevo che non è una cosa carina incontrare qualcuno che si conosce e ignorarlo per leggere. Chiusi il libro quando si cominciarono a vedere dai finestrini le prime case di Cefalù: l’avevo finito. Poco più di due ore di lettura. Credo sia il mio record assoluto.“D’un tratto nel folto del bosco” è più una fiaba che un racconto. Non sfigurerebbe affatto in un libro dei fratelli Grimm. Amos Oz dà prova di tutta la sua maestria descrittiva nel raccontare di un paese stregato, senza tempo e senza nome, da cui misteriosamente sono sparite tutte le forme di vita animale tranne gli uomini. E a nulla valgono le domande dei bambini curiosi, a nulla valgono le ombre che strisciano silenziose nella notte: gli adulti non parlano, non vogliono riportare a galla segreti che sono tenuti nascosti nel fondo di un pozzo buio. Eppure trapela qualcosa di strano, in alcuni gesti, in alcuni atteggiamenti, come i curiosi disegni della meastra Emanuela, o la solitudine del pescatore Almon, o lo spargere briciole della fornaia. E Mati e Maya, spinti dalla curiosità e dall’incoscienza dei bambini, decidono di partire per il loro viaggio avventuroso, in cerca del villaggio nel quale credono si siano rifugiati gli animali scomparsi. E nel folto del bosco trovano Nimi, lo strano bambino malato di nitrillo, Nehi, il demone del bosco, e la triste verità che si cela dietro questi personaggi.
Con la sua straordinaria capacità di raccontare sia attraverso le voci che attraverso i silenzi, Amos Oz ci conduce, attraverso gli occhi dell’innocenza, in un viaggio onirico e ultradiemensionale, a contatto con profondi e struggenti umori dell’animo. E come in tutte le fiabe che si rispettino, ci consegna una morale, affidata al profondo valore della lingua degli animali, una lingua che prevede tanti suoni, ma non la possibilità di articolarli per formare parole come esclusione, emarginazione, diversità. Cosa in cui invece i rappresentanti della razza umana si rivelano maestri.
Iscriviti a:
Post (Atom)