 I romanzi che hanno come protagonista non uno o due personaggi, ma un’intera famiglia, mi hanno sempre affascinato molto. Se devo trovare un motivo preciso per questo interesse, forse quello più logico sarebbe la mia innata curiosità per i comportamenti umani. Seguire le vicende di più personaggi, ognuno con caratteristiche diverse, che si trovano di fronte agli stessi eventi, mi diverte e mi intriga molto. Ma sento che c’è di più, che non è solo questo il motivo. Credo che la vera ragione stia nella mia famiglia. Le famiglie dei miei genitori erano entrambe molto numerose, ma mentre i componenti di quella di mio padre hanno sempre vissuto vite separate, per il mio ramo materno le cose sono andate diversamente. In un certo senso, anche sulla mia famiglia si potrebbe scrivere un romanzo, e se fossi nato una ventina d’anni prima, non è da escludere che l’avrei fatto io stesso. Per me, stare ad ascoltare i racconti del passato, in occasione delle grandi riunioni di famiglia, non è mai stato una seccatura, anzi era un piacere. Con la mia immaginazione, seguivo le vicende dei miei nonni e dei loro fratelli, attraverso periodi belli ed altri meno belli, e considero questo bagaglio di memorie come un vero tesoro. Credo sia per questo che mi piacciono le saghe familiari. “I vicerè”, “Il Gattopardo”, “Cent’anni di solitudine”, per citare solo i più classici, li ho letti tutti con grande passione, ma non per questo non mi hanno coinvolto anche romanzi più moderni.
I romanzi che hanno come protagonista non uno o due personaggi, ma un’intera famiglia, mi hanno sempre affascinato molto. Se devo trovare un motivo preciso per questo interesse, forse quello più logico sarebbe la mia innata curiosità per i comportamenti umani. Seguire le vicende di più personaggi, ognuno con caratteristiche diverse, che si trovano di fronte agli stessi eventi, mi diverte e mi intriga molto. Ma sento che c’è di più, che non è solo questo il motivo. Credo che la vera ragione stia nella mia famiglia. Le famiglie dei miei genitori erano entrambe molto numerose, ma mentre i componenti di quella di mio padre hanno sempre vissuto vite separate, per il mio ramo materno le cose sono andate diversamente. In un certo senso, anche sulla mia famiglia si potrebbe scrivere un romanzo, e se fossi nato una ventina d’anni prima, non è da escludere che l’avrei fatto io stesso. Per me, stare ad ascoltare i racconti del passato, in occasione delle grandi riunioni di famiglia, non è mai stato una seccatura, anzi era un piacere. Con la mia immaginazione, seguivo le vicende dei miei nonni e dei loro fratelli, attraverso periodi belli ed altri meno belli, e considero questo bagaglio di memorie come un vero tesoro. Credo sia per questo che mi piacciono le saghe familiari. “I vicerè”, “Il Gattopardo”, “Cent’anni di solitudine”, per citare solo i più classici, li ho letti tutti con grande passione, ma non per questo non mi hanno coinvolto anche romanzi più moderni.“Il quinto esilio” è uno di questi. Non c’è bisogno di leggere la nota biografica nel risvolto di copertina per capire che Boris Biancheri, l’autore, ha viaggiato molto, e già il nome, mezzo russo e mezzo italiano, ci fa capire che il viaggio è un tema fondamentale della sua vita. E visto che un romanzo non è altro che un pezzo dell’anima di chi lo scrive, anche in questo libro si parla di viaggi. Tra i metafisici paesaggi del Baltico, distese grigie in cui si accendono improvvisi sprazzi di colore, si snoda la storia della famiglia Grabhau, una famiglia che porta come triste marchio distintivo quello dell’esilio. Per loro l’esilio non è una condanna, non è neanche una sofferenza, ma si potrebbe dire che è un mestiere, una vocazione. Perché da continui esili è scandita la melodia della storia di questa famiglia, dal capostipite, cavaliere cinquecentesco costretto ad abbandonare la patria natia per approdare sul Baltico a portare ‘la luce di Cristo’, fino alle nuove generazioni, che arriveranno addirittura nel Nuovo Mondo. E in ogni luogo un cui la famiglia si trova a vivere, con i nuovi componenti che rimpiazzano i vecchi, troviamo modi nuovi di adattarsi all’ambiente, di superare l’isolazionismo del migrante, di chi della sua patria può avere solo ricordi e storie, mai concretezze. Il cammino dell’ultimo erede dei Grabhau si snoda anche attraverso l’Italia, a Roma, per poi concludersi, dopo la seconda guerra mondiale, negli Stati Uniti.
Ma nel loro peregrinare, i Grabhau si portano appresso un palpito del cuore, una condizione esistenziale, un assetto morale che li porta a muoversi sul filo di un vertiginoso senso di vuoto, di un’estraneità quasi patologica verso il mondo che li circonda, salvo poi emergere con scatti di sensualità, passione e coraggio. E forse, il vero significato che Biancheri ci vuole comunicare con tutto il romanzo, non è altro che l’immane senso della storia, una riflessione sull’identità, del singolo come del nucleo, e sul valore del passato come garanzia di questa identità.
“Era certo, per esempio, che presto sarebbe venuta la rivoluzione e aveva deciso di emigrare. Non era un pensiero sorprendente: i von Grabhau erano infatti, se così si può dire, degli specialisti dell’esilio”.
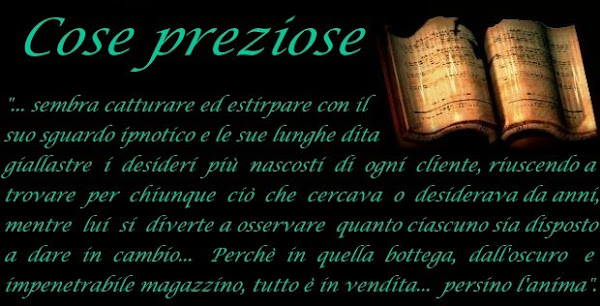


Nessun commento:
Posta un commento